In memoriam René Guénon

A quasi settant’anni dalla morte dello Shaykh ‘Abd al Wâhid Yahyâ, riteniamo opportuno tentare di dissipare alcuni malintesi dottrinali la cui chiarificazione poteva sembrare acquisita alla luce dell’opera di René Guénon, ma che sembrano invece assumere un carattere ricorrente, soprattutto quando dalla fase teorica o «speculativa» si cerchi di passare a quella pratica o «operativa»; contemporaneamente è necessario denunciare concezioni antitradizionali che ricorrono ai nostri giorni e che ricevono inoltre l’appannaggio di alcune autorità ufficiali, sia exoteriche sia esoteriche, non solo dell’Occidente, ma anche dell’Oriente.
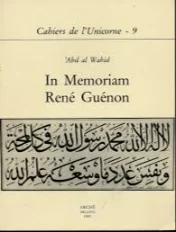
«Cahiers de l’Unicorne» Archè Milano, 1981
Non dimentichiamo soprattutto che il nostro ultimo e unico scopo è la Conoscenza, e che questa si ottiene solamente tramite la «realizzazione spirituale», e se non possiamo far meglio che rinviare, per un’esatta comprensione di tali termini, all’opera già menzionata, qui possiamo soltanto dire, a seguito dell’esperienza di certe incomprensioni, ciò che tali termini non esprimono. Così, la Conoscenza non è una sorta di enciclopedismo di nozioni tradizionali, mentre la «realizzazione spirituale» non è semplicemente il risultato dell’addizione: dottrina più iniziazione.
L’iniziazione, d’altra parte, non è un punto d’arrivo dove le conoscenze dottrinali sono immediatamente e miracolosamente realizzate, ma, come la parola stessa suggerisce, è soltanto l’«inizio» di un processo di purificazione che si protrarrà per tutta la vita e il cui esito non dipende da noi, ma dalla Provvidenza; inizio tuttavia indispensabile al fine di ricevere l’influenza spirituale e i mezzi propri di un determinato esoterismo, che di tale esito costituiscono le necessarie fondamenta.
È pertanto evidente che non vi è iniziazione senza esoterismo, ma l’iniziazione rappresenta proprio l’entrata in un’organizzazione esoterica, così come non vi è organizzazione esoterica né esoterismo al di fuori di un exoterismo al quale si appartiene già, sia pure «in vista» di tale iniziazione; ma se è ben vero che in circostanze diverse di tempo e di luogo sono esistite, così come ancora esistono, espressioni exoteriche la cui forma non era religiosa, è chiaro che per noi occidentali, oggi, l’exoterismo è necessariamente una religione.
È d’altronde provvidenziale che sia così, perché se gli uomini più vicini nel tempo o nella loro integrità alla Tradizione primordiale non avevano o non hanno la necessità di una forma religiosa, questa è sicuramente la più adatta a noi a causa del nostro stato di occidentali decaduti dell’epoca moderna, e il fatto che possiamo immaginare invece lo stato degli uomini primordiali e anticipare intellettualmente la nostra «reintegrazione» in esso non cambia minimamente la nostra attuale condizione di uomini ai quali, al contrario, è necessario il sostegno che ci offre proprio la religione.
L’appartenenza a una religione determinata non è pertanto solamente una formale conditio sine qua non dell’iniziazione all’esoterismo corrispondente, ma la qualificazione naturale necessaria, nell’adesione a tutte le sue modalità «fideistiche» o «virtuali», che costituisce il terreno fertile per far germogliare il seme di un’iniziazione, onde evitare sia la sua dispersione sia la sua deviazione, ove non fosse ancora stata raggiunta la giusta predisposizione.
Non si tratta di aderire a una religione solo in forma letterale, apprendendone la «lingua sacra», la «dottrina teologica» e la «tecnica rituale», ma soprattutto di saperne vivere lo «spirito», di divenire «religiosi», non nel senso di appartenere a un ordine, come si dice in Occidente, ma nel senso di abbandonare la nostra indipendenza profana per accettare invece la dipendenza da quel Principio al quale, conformemente al significato etimologico della parola «religione», noi ci «ricolleghiamo», e ciò sia exotericamente sia esotericamente.
È questa, infatti, la differenza essenziale fra sacro e profano, e se esistono presunte vie di realizzazione più o meno «sinistre», che vorrebbero trascurarla in vista di scopi contingenti o fenomenici, sarà proprio nel senso di una «profanazione»: ci domandiamo, in effetti, quali risultati si possa pretendere di ottenere quando si rinuncia a seguire le leggi date da Dio, o anche solamente quelle della «natura», e a quale santità si tenda con l’ipocrisia e la disonestà, la vanità e l’invidia, l’arroganza e la cattiveria, l’immoralità o l’amoralità.
Di che genere di realizzazione si tratterebbe allora? Forse di quella di un «individuo assoluto» non più inteso come sinonimo del Sé, ma al contrario come ipertrofia dell’«io», quando si sa che «finché noi siamo, Lui non è»? Non abbiamo ancora capito che dobbiamo «contenerci» in una forma religiosa che ci riconduca a una dimensione teocentrica, perché solo a partire dal centro della nostra individualità potremo aspirare a elevarci alla realizzazione di una Personalità che ci trascende?
Una volta approdati al piano pratico abbiamo forse relegato al piano teorico la necessità di «sacrificare l’io», quella di saper «morire prima di morire» e di «adorare Iddio, Allâh, come se Lo vedessimo, perché anche se noi non Lo vediamo, Lui ci vede», per cercare invece di innalzarci da soli, come chi volesse elevarsi tirandosi per i capelli, forti della nostra presunzione dottrinale o del nostro rigore tecnico, tralasciando di vigilare sulla sincerità delle nostre intenzioni, come consumati arrivisti che tentino di ingannare Iddio e se stessi?
Alla stessa «profanazione», intesa qui nel senso di tenersi «fuori del tempio», si possono ricondurre tutti i sottoprodotti della vita tradizionale che sembrano sedurre colui che, una volta «discesi» dal dominio della metafisica pura a quello della pratica rituale, scoprono che il loro effettivo interesse era lo studio delle possibilità di realizzazione spirituale più ancora della realizzazione stessa, e, incapaci di operare il distacco dai compiacimenti intellettualistici del passato per quello che sembra loro essere un «salto nel vuoto», cercano di colorare la propria «vita ordinaria» con utopie proselitarie, politico-interventiste o escatologiche; finalità che ciascuno sarebbe libero di perseguire se soltanto non volesse coinvolgere anche gli altri nella propria «caduta».
Ecco dunque quanto un certo pseudo-Islâm decadente dei giorni nostri pretenderebbe anch’esso predicare in Occidente, soprattutto a occidentali che si sono convertiti Islâm, creando così una difficoltà di rapporti fra il musulmano «guénoniano» e il musulmano d’origine, difficoltà che nasce innanzitutto dal fatto che, per quest’ultimo, la conversione all’Islâm implica il ripudio del Cristianesimo, la cui validità, malgrado le affermazioni completamente opposte dello stesso Corano, tende a essere relegata, nella migliore delle ipotesi, all’epoca preislamica, da parte della grande maggioranza dei musulmani, a qualsiasi contesto exoterico o esoterico essi appartengano.
E ciò non solamente per quanto riguarda la pratica generale, cosa che sotto diversi aspetti potrebbe essere concepibile, ma perfino nel suo stesso principio, dal momento che per loro non è credente, benché sia praticante e ortodosso, non solo chi non riconosce la venuta del Profeta Muhammad (çalla-Llâhu ‘alayhi wa sallam) ma perfino chi, pur avendolo riconosciuto e avendo aderito all’Islâm e alla sua Legge, mantenga ancora la convinzione dell’attuale validità dei messaggi profetici precedenti, per non parlare di quella di tradizioni considerate nello stretto senso storico della parola come «non abramiche».
Lo stesso esclusivismo si manifesta anche a livello esoterico, quando il guénoniano non sembra vedere una grande differenza fra le turuq (ossia le organizzazioni iniziatiche islamiche), mentre il musulmano d’origine che abitualmente non l’ha scelta per vocazione o per affinità, ma è nato nella sua tarîqah seguendo una tradizione familiare, tende a considerarla come una specie di «clan» superiore a tutti gli altri e a non riconoscere come buoni credenti non solo gli appartenenti a altreturuqo ad altre religioni, ma nemmeno i suoi stessi fratelli musulmani.
Ciò fa sì che certe turuq, o perlomeno alcune delle loro sedi (zawâyâ) che furono nel passato legittimi centri per la propagazione dell’Islâm o per l’indipendenza di alcuni paesi islamici, oggi diventino gli strumenti più o meno coscienti di quei movimenti attivisti e militanti sorti a volte proprio dalla deviazione di una tarîqah particolare, a imitazione di quelle che furono le tendenze missionarie cattoliche per coprire le mire espansionistiche ai tempi del colonialismo europeo. Un’anacronistica crociata alla rovescia, segno che quella che si ha di fronte non è più che la maschera del vero Islâm.
La situazione al giorno d’oggi è aggravata non solo dall’importanza economica e strategica acquisita da alcuni paesi islamici o sedicenti tali, e pertanto divisi e opposti tra le abituali tendenze capitalistiche o progressiste, conservatrici o rivoluzionarie, ma anche per la strumentalizzazione dell’Islâm ai fini delle superpotenze o «infrapotenze» che siano, col pretesto di un ritorno ufficiale e globale a un fondamentalismo islamico, a un’ingiustificata valorizzazione della lettera laddove lo Spirito non è più presente.
Non è sorprendente, allora, che l’ultima parola dell’estremismo militante islamico che incita alla «rivolta» e al terrorismo in vista della costituzione di un califfato rinnovato o «impero», non solo nei paesi islamici ma nel mondo intero, non provenga dall’Oriente ma sia al contrario l’espressione della parodia della tarîqah, che colui che viene chiamato «l’esoterista René Guénon» auspicava come possibilità di salvezza e di realizzazione spirituale per una certa élite.
È dunque auspicabile che, se questa organizzazione deve costituirsi o se, perlomeno, sopravviveranno alcuni ambienti veramente tradizionali che vi si ispirano, questi assumano, anche esteriormente, quel carattere autonomo, selettivo e segreto che permetteva l’azione delle organizzazioni iniziatiche cristiane ai tempi dell’Inquisizione – quegli stessi tempi che forse oggi anche l’Islâm sta attraversando nell’ineluttabilità della propria decadenza, destino comune a tutte le religioni –, e ciò affinché sussista almeno qualche seme al momento della fine, quella che non sarà altro che la fine di un mondo.
Dovrebbe infatti essere chiaro che – a parte i casi limite di alcuni fanatici estremisti che sembrano aver tagliato i ponti e le «radici» con il proprio passato, forse non in quanto cristiano, ma in quanto «proprio» – le motivazioni che hanno portato a quell’atto di volontà costituito dalle nostre «conversioni» non sono dovute a un rigetto del Cristianesimo, ma a una accettazione dell’Islâm, o meglio all’inserimento nella Tradizione primordiale (dînu-l-qayyîmah) nella sua ultima espressione che, come tale, abbraccia le verità delle precedenti rivelazioni e rivivifica le possibilità della realizzazione spirituale basata sulla conferma dei messaggi antecedenti.
Non troviamo, in effetti, nella sharî’ah, la legge islamica, nulla che possa abrogare i dieci Comandamenti, né questi avrebbero potuto costituire un ostacolo al nostro sviluppo spirituale; l’ostacolo sarebbe piuttosto da ricercare nella decadenza dell’organizzazione exoterica e nell’inaccessibilità di organizzazioni esoteriche, altre conseguenze delle influenze razionaliste e sentimentali che non appartengono al Cristianesimo originario, ma all’Occidente moderno.
Se queste influenze ci hanno in qualche modo reso invisa la nostra religione d’origine alla quale abbiamo la tendenza ad associarle, per reazione, probabilmente, abbiamo cercato di prescindere dagli aspetti logici o emotivi che pure esistono in ogni tradizione come parte integrante dell’uomo e pertanto «materia» necessaria alla mutazione alchemica, per mettere invece l’accento soprattutto sugli aspetti dottrinali e tecnici. Come se la lettura di René Guénon ci avesse condotto automaticamente al di là delle nostre limitazioni ontologiche, qualificandoci per un processo titanico di realizzazione basato quasi esclusivamente su una tecnica esente da ogni partecipazione «umana» e indipendente da ogni provvidenziale intervento della Grazia divina.
Ora, se abbiamo ritrovato nei libri le verità tradizionali, per «realizzarle» occorre saper ritrovare in noi stessi alcune «virtù» probabilmente inariditesi sui banchi di scuola, e nel nostro comportamento la corrispondenza alla legge che ne consegue. Le «materie d’esame» non sono la conoscenza dell’arabo, la velocità nella lettura del Corano, o ancora lo studio comparato delle religioni e delle confraternite, ma, per esempio, il pentimento (tawbah), lo sforzo (jahd), l’abbandono a Dio (tawakkul) e osiamo perfino menzionare l’amore divino (mahabbah), qualità che si ritrova anche nel taçawwuf, e che tuttavia ha allontanato alcuni dalla pratica.
Che si tratti anche di imparare una tecnica, è ben vero, ma non si tratta di un processo fisico, come quello di uno stantuffo che, senza alterare i propri elementi meccanici, produce un «soffio», ma di un procedimento «chimico», o, per meglio dire, alchemico, come quello dell’idrogeno e dell’ossigeno che, incontrandosi, producono l’acqua, diventano acqua e perdono così le loro caratteristiche di gas.
Si tratta, infatti, di diventare altra cosa, ma per diventare bisogna essere, e per essere bisogna fare, e per fare bisogna sapere, e per sapere bisogna volere. Ma non basta volere, non basta sapere, non basta fare, se non si «è», cioè se non si usa di tutta la nostra «essenza» umana, ivi comprese le dimensioni mentali (presenza e concentrazione) e affettive (sincerità e trasporto), per renderci ricettivi a ciò che la trascende e che «attraversandola», in shâ Allâh, a Dio piacendo, ci trasforma.
Come le verità essenziali delle differenti tradizioni coincidono in Dio che è Uno, così sembrano coincidere le tecniche della realizzazione spirituale dell’uomo, che in definitiva è sempre lo stesso. Tuttavia tali similitudini non vanno prese per delle equivalenze, e le forme delle differenti rivelazioni, che manifestano ciascuna un differente aspetto della Verità, sono fra loro divergenti; ugualmente le strutture tramite le quali viene canalizzata l’influenza spirituale propria a una particolare rivelazione, adattata a specifiche esigenze di tempo e di luogo, non sono intercambiabili con quelle di altre rivelazioni.
Noi non possiamo dunque «cristianizzare» l’Islâm, nemmeno da un punto di vista metodologico, né colorare la nostra partecipazione al taçawwuf con un atteggiamento cristiano «mistico», quale per esempio il distacco ascetico dalla vita e dal mondo. Né possiamo aspettarci, o pensare di poter costituire ex novo, una struttura monastica, foss’anche di ispirazione esicastica, nell’Islâm che non ha né monachesimo né clero. Infine, non possiamo pretendere che l’Islâm, per il solo motivo che noi l’abbiamo incontrato adesso, sia rimasto lo stesso di quello del tempo del Profeta (çalla-Llâhu ‘alayhi wa sallam) o pensare che, non essendo più tale in Oriente, noi possiamo ricrearlo al giorno d’oggi in Occidente.
D’altra parte, ciò che a noi interessa è la reintegrazione dell’uomo nel suo stato primordiale e non la ricostruzione storica delle condizioni della vita tradizionale che, se l’Islâm è eterno e universale, cambiano secondo i secoli e le latitudini. L’Islâm vero è quello che ci permette di viverne lo spirito e di seguirne la Legge dovunque ci si trovi e in ogni momento del ciclo storico, anche quello ultimo, quando è detto che l’Islâm si propagherà in nuove regioni della terra.
Non si dovrebbero, dunque, formare delle comunità islamiche distaccate dal resto dell’umanità, che potrebbero servire d’appoggio per anacronistiche restaurazioni o per giochi politici di cui siamo stati e siamo tuttora testimoni in Europa. Ugualmente non sarebbe islamico nella metodologia del sufismo rigettare le concomitanze necessarie alle esperienze della vita, e rifiutare di assumere le proprie responsabilità familiari e professionali, dal momento che questa accettazione rappresenta, a prescindere dalle personali caratteristiche e aspirazioni, una maggiore aderenza alla realtà intesa come espressione della Volontà divina.
Noi non rifiutiamo né la vita né il mondo in sé, ma solamente il mondo moderno e la vita antitradizionale, e se questi rappresentano degli ostacoli al nostro sviluppo, è nella misura in cui noi stessi, figli dell’Occidente moderno, siamo ancora profani. Sarà possibile superare questi ostacoli con un mutamento interiore che dovrebbe essere lo scopo della nostra aspirazione iniziatica, della nostra vocazione spirituale, di modo che quelli che ci sembravano degli ostacoli diventino i supporti per la nostra realizzazione.
Si direbbe, al contrario, che vogliamo fuggire le difficoltà della vita, comuni a tutti gli uomini, rifugiandoci nella torre d’avorio della nostra appartenenza tradizionale, piena di affinità elettive e di abitudini compiacenti, rifiutando tutti i contatti e i doveri richiesti dalla nostra situazione umana. Noi pretendiamo fare dei nostri interessi tradizionali i cardini delle nostre attività.
Ma il taçawwuf è la misura della nostra vita e non certo l’evasione da questa. Non è la consolazione per la mancanza di comprensione o di sentimenti umani né il surrogato delle soddisfazioni della vita professionale o sociale, né può divenire esso stesso una «professione» o una «carriera» nella quale trovare i mezzi per la propria espressione personale o per la propria sopravvivenza.
Molti Shuyûkh, in Oriente, sono capifamiglia che esercitano o hanno esercitato un’attività «profana», se così si possono chiamare le attività mediche, giuridiche, militari o amministrative. La maggior parte dei loro discepoli non si interessa accademicamente al taçawwuf, ma lo vive, così come un musulmano va alla moschea per pregare, e non per parlare dell’Islâm, e quando ne esce continua a vivere da buon musulmano, anche con i non credenti, e nella sua professione profana.
Ai capi dei monasteri tibetani distrutti dall’invasione cinese il Dalai Lama indirizzò un discorso che è possibile leggere nel libro Nato in Tibet, e il cui senso è il seguente: «Sembra che sia passato il tempo dell’insegnamento tramite le organizzazioni monastiche; forse ora occorre ritornare all’insegnamento orale e segreto che ci eviterebbe le persecuzioni vissute finora».
Un giorno un inviato del governo algerino, conscio del potere rappresentato dallo Shaykh al ‘Alawî gli propose di collaborare con il governo che in cambio avrebbe fatto chiudere tutte le sedi (zawâyâ) delle altre turuq. «Sarebbe meglio che il governo chiudesse le mie zawâyâ» rispose lo Shaykh «e lasciasse le altre aperte, perché queste ultime hanno bisogno di esistere, mentre i miei fuqarâ (discepoli) portano la zâwiyah nei loro cuori».
Testo pubblicato nel n.9 dei Cahiers de l’Unicorne, Archè Milano, 1981