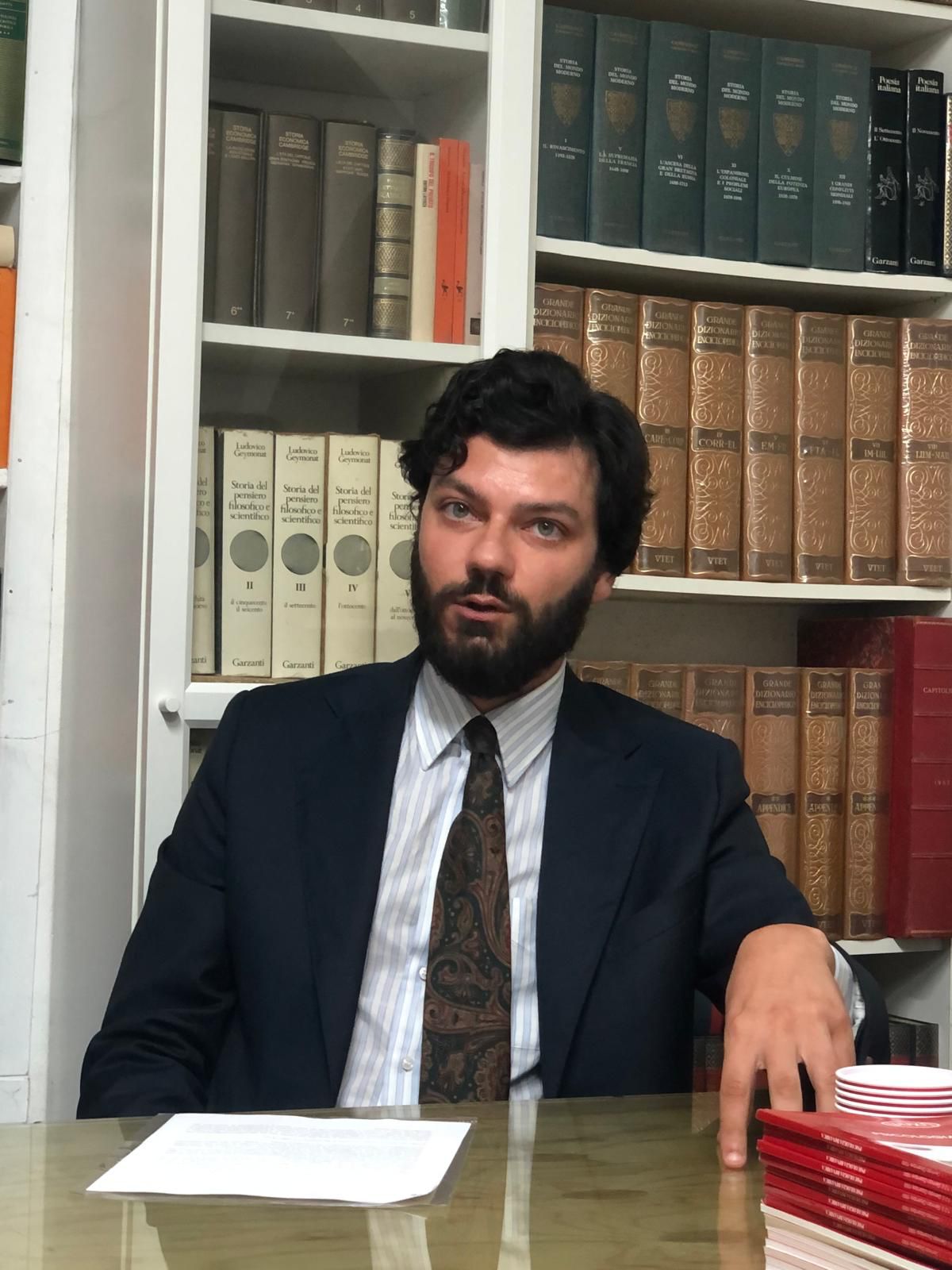Università mediterranea, la grande opportunità per l'Italia
Il "Patto per il Mediterraneo" della Commissione europea è l'ennesima occasione da non perdere

La Commissione Europea e l’alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza hanno emanato nell’ottobre del 2025 un documento dal titolo “Il patto per il Mediterraneo. Un mare, un patto, un futuro”.
Il documento è stato redatto con il supporto dei Paesi del Golfo e di dieci Paesi mediterranei non facenti parte dell’Unione: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. Alla redazione del patto ha inoltre contribuito la Anna Lindh Foundation.
Il documento dichiara la necessità per l’Europa di focalizzarsi sul Mediterraneo e di rinnovare le relazioni tra i Paesi, appartenenti a tre continenti, che si affacciano su questo mare.
Il patto è articolato in tre pilastri: persone, economia sostenibile e interconnessa, sicurezza e gestione dei flussi migratori. Concentrandoci sul primo pilastro, possiamo osservare come la Commissione proponga, nell’espletamento di un adeguamento delle relazioni tra le sponde del Mediterraneo, la creazione di una università mediterranea con campus situati in diverse città, la nascita di un centro mediterraneo per la diplomazia e il supporto a iniziative di mentoring intergenerazionale.
È un segnale rassicurante il fatto che, in una fase storica di scontro e chiusura, le istituzioni europee cerchino di percorrere delle piste di dialogo e della cooperazione. Puntare su cultura e dialogo come supporti prioritari rispetto all’economia e alle transazioni finanziare è inoltre un dato di grande novità. L’auspicio è quello di non dilapidare l’ennesima opportunità di confronto e dialogo sullo spazio mediterraneo a causa di ingenuità puerili, ingolfamenti burocratici e prospettive provinciali.
Cultura e diplomazia, le grandi assenti della storia contemporanea
Ciò che appare evidente in questa epoca è l’incapacità di realizzare il dialogo. Non perché manchino i contesti e le occasioni ma a causa di un regresso culturale e un offuscamento intellettuale che impediscono all’intelligenza di proporre soluzioni, di ordinare le priorità e di cercare di percorrere un umanesimo che non metta la megalomania degli uomini al centro. Le conseguenze, a livello internazionale, sono state la scomparsa di una cultura della politica nazionale e internazionale e l’impotenza della diplomazia.
La parola cultura, oggi spesso utilizzata per rivendicare delle egemonie, sia a livello locale che a livello globale, ha un significato preciso, differente rispetto a quello che sta assumendo oggi. Deriva dal verbo latino colere, che ha come primo significato quello di “coltivare”, “prendersi cura”, in riferimento ai campi e all’agricoltura. Questo verbo si usa in latino anche per i luoghi e in questo caso assume il significato di “frequentare”, “abitare”. C’è però anche un ulteriore applicazione di questo termine che è quella religiosa. Ancora oggi in italiano la parola “culto” deriva infatti dal participio perfetto (cultus) del medesimo verbo. In questa accezione il verbo si applica alla divinità e alle virtù come la verità, la giustizia, la fede e si può tradurre con “mettere in pratica”, “onorare”. La cultura, dunque, non è un accumulo quantitativo di nozioni ma è il prendersi cura dell’uomo nella sua integralità. Nella dimensione interiore ed esteriore, verticale e orizzontale. Riscoprire la cultura italiana ed europea aiuterà a riscoprire con meraviglia l’essenza primigenia dell’uomo, la natura dell’Oriente e dell’Occidente per ciò che sono veramente, l’importanza delle relazioni, la necessità di rispettare il patrimonio ricevuto in eredità senza piegarlo a visioni partitiche. Questa è l’apertura universale che si può seguire se gli europei si indirizzano verso una mentalità che non è affatto nuova ma è sempre appartenuta loro prima che l’individualismo e il materialismo la corrompessero.

Si tratta di superare Machiavelli attraverso Dante: se per Machiavelli il fine della politica è l’esclusiva funzionalità strategica, per Dante concentrarsi meramente sull’utilitarismo delle azioni della politica interna ed estera porta a una confusione della naturale gerarchia delle cose che sfocia inevitabilmente nel disordine. Occorre senz’altro perseguire una strategia ma al di sopra di questa bisogna riconoscere una Signoria che non è quella della vanagloria umana.
Anche la diplomazia, nella migliore delle ipotesi, si è ridotta a un mero formalismo inconcludente e inefficace. In un articolo pubblicato sulla rivista Foreign Affairs il diplomatico statunitense Aaron Wess Mitchell mette in evidenza come nell’ultimo trentennio le cancellerie occidentali abbiano dimenticato cosa sia la diplomazia. L’autore evidenzia come la convinzione che la storia fosse finita abbia portato i politici occidentali a smobilitare la diplomazia a favore dell’esercizio del mero potere economico e militare. Mitchell si stupisce che, quella che lui definisce “ancient wisdom”, una “saggezza antica”, fatta di dialogo, sia stata completamente abbandonata a favore di una politica di potenza espansionistica e questo è stato un criterio ordinatore per tutte le forze politiche che abbiano governato negli ultimi decenni. L’autore prosegue inoltre affermando che il personale diplomatico occidentale e americano in particolare non abbia una formazione che non sia di carattere militare ed economico e che bisogna dunque ripartire dalle basi del dialogo e del confronto perché oggi l’Occidente non è più nella posizione di imporre con prepotenza il proprio predominio A. Wess Mitchell, The Return of Great-Power Diplomacy, in “Foreign Affairs”, May/June 2025, pp. 24-39..
La cultura del dialogo è stata dunque sopraffatta dalla tecnica del dialogo ma il metodo, se svuotato di senso e di finalità, si riduce a una mera etichetta, formalista e inefficace. Occorre ripartire da qui: dal rinnovamento della cultura del dialogo, dalla ricerca di un nuovo linguaggio e dall’applicazione di un nuovo metodo, che tenga conto dei tempi e degli spazi in cui l’Italia e l’Europa si trovano a essere e ad agire.
Il ruolo dell’Italia
All’interno della cornice giuridica del Patto per il Mediterraneo e nell’urgenza di arginare la barbarie che inevitabilmente esploderà in un Occidente che ignora la cultura, quale può essere il ruolo dell’Italia? L’Italia può avere una funzione privilegiata non solo per la sua posizione geografica e per la sua storia ma soprattutto per il contributo a una nuova cultura del dialogo e a una nuova prospettiva europea sul Mediterraneo. Non basterà infatti costruire degli atenei lungo le sponde mediterranee e realizzare un programma di Erasmus tra Europa, Africa e Asia per perseguire un nuovo umanesimo. Il problema non è tanto cosa si fa ma con quale prospettiva. Se l’approccio a questo programma della Commissione Europea è quello affaristico e bottegaio, dell’elefantiasi legislativa tipica delle istituzioni europee, di una presunta superiorità basata sul rispetto dei diritti umani, questo Patto non avrà una grande efficacia. Se invece l’Italia saprà imprimere la prospettiva della ricerca e del sapere, priva di pregiudizi accademici e ideologici, allora potranno nascere delle aperture ancora più proficue delle semplici collaborazioni scientifiche e l’Europa potrà avere un’occasione per uscire dal letargo della ragione e dall’inconsistenza storica e persino economica che ormai la caratterizzano. Già con il Piano Mattei l’Italia ha mostrato di comprendere l’importanza delle speciali relazioni che da millenni connettono il Mediterraneo. Con questa nuova direzione strategica dell’Europa l’Italia ha un’occasione di implementare il Piano Mattei, di valorizzare la ricchezza del suo patrimonio nel Sud e di rendere viva l’eredità sapienziale di una storia fatta di maestri, sapienti e intellettuali.

La storia europea, se si vuole davvero renderla viva e non chiuderla nella teca dei bei ricordi, insegna che l’Occidente ha incarnato il carattere di una civiltà brillante quando è stato in autentico dialogo con i popoli che abitano i “discordanti liti” Paradiso, IX, 85., come li definisce Dante, di quel mare oggi così travagliato. L’Università del Mediterraneo e il Centro per la diplomazia mediterranea sono dunque delle occasioni di instaurare un dialogo autentico e non il solito monologo dell’accademia occidentale che ritiene di dover insegnare e imporre il proprio modello educativo.
L’Italia può accompagnare l’Europa a ricercare una visione spirituale della vita, della cultura e del mondo, libera dalla serviti delle ideologie artificiali, dal relativismo, dall’individualismo e dalle false promesse di affaristi della politica e dell’economia, per perseguire una politica di reale benessere e per realizzare il senso autentico della polis, che è quello di orientare i propri cittadini verso il Bene dell’Intelletto.
Non sarà il solo Patto per il Mediterraneo a realizzare tutto questo ma la politica ha il dovere di percorrere le possibilità che si presentano perché queste sono sempre più ristrette e non è detto che si ripresentino.