L'ombelico del mondo

Fra tutti gli agglomerati urbani dalla storia millenaria, Gerusalemme rappresenta, forse, quello che meglio incarna, nel suo intreccio di popoli e culture non meno che nella sua vicenda tormentata, financo nella sua stessa topografia, l'epicità e la drammaticità dell'umana esistenza. Il mistero di tale fortuna trova spiegazione nella sua bifronte essenza, spirituale e materiale, conseguita mediante la continua risignificazione della sua dimensione spaziale. Alture, rovine, vallette, burroni, monumenti, sepolcri: tutto rimanda ad altro, perpetrando, in un continuo gioco di specchi, quel moto di costruzione identitaria che ha nel sostrato giudaico il proprio primo motore, del quale la galassia cristiana e quella musulmana sono, sì, eredi ma altrettanto compartecipi. Sin dalle Scritture ebraiche, Gerusalemme assume i contorni d'una città ideale, ulteriore, terrena e celeste al tempo stesso. Una città orizzontale, sì, ma altrettanto verticale. Capace, cioè, di esemplificare quella relazione tra Dio – il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe; il Dio Padre di Gesù; il Dio di Muḥammad – e gli esseri umani. È su questi presupposti, pertanto, che si gioca il tentativo continuo di appropriarsene anche con la forza.
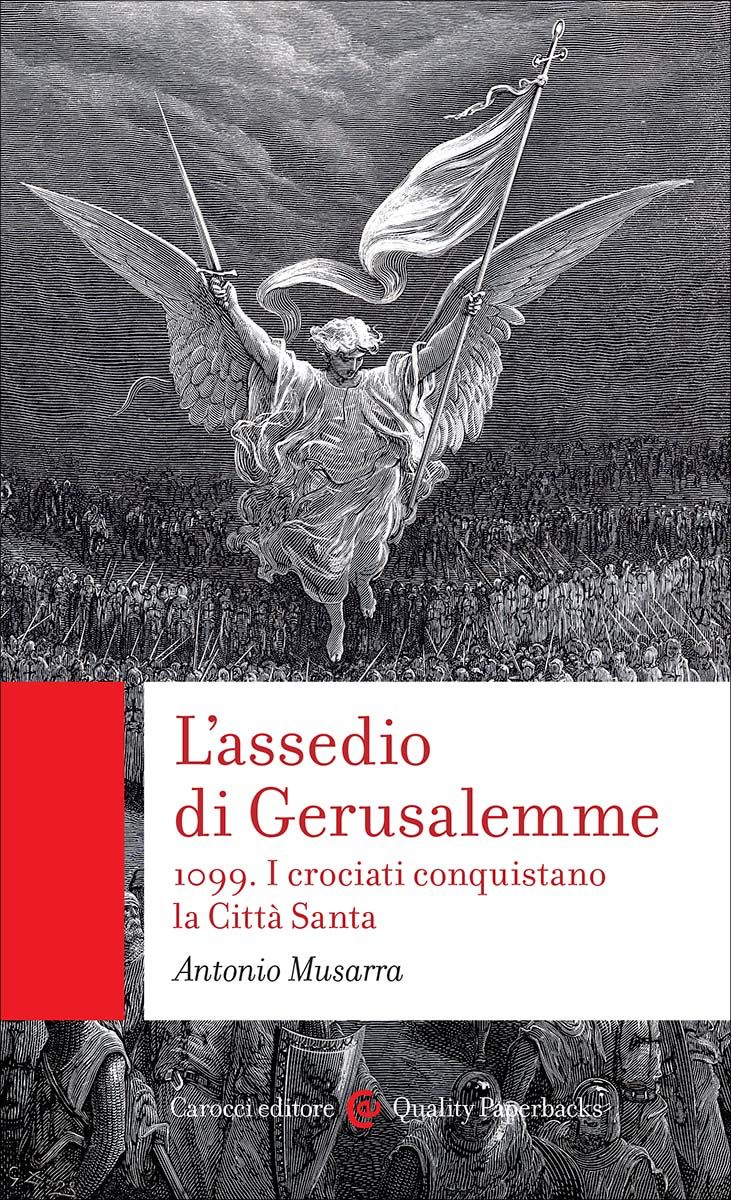
Che tale coscienza affondi le radici nel testo biblico è un dato di fatto. Nel Deuteronomio (Devarìm), la città compare come il «luogo che il Signore vostro Dio avrà scelto fra tutte le vostre tribù, per stabilirvi il suo nome» (Dt 12,4-5). È, tuttavia, nel libro dei Salmi che Gerusalemme assurge a luogo cosmico, verticale almeno quanto orizzontale, scelto prima dei tempi, destinato a durare per l'eternità. Nessun altro posto riunisce in sé tali elementi. È quanto si legge, ad esempio, in Sal 46 (45),5-6:
5 Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio,
la più santa delle dimore dell'Altissimo.
6 Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare.
Dio la soccorre allo spuntare dell'alba
Ma si pensi, altresì, ai versi di Sal 48 (47),2-4:
2 Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
La tua santa montagna, 3 altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra.
Il monte Sion, vera dimora divina,
è la capitale del grande Sovrano.
4 Dio nei suoi baluardi,
un baluardo si è dimostrato.
Il termine «Sion», associato, nel tempo, ad alture diverse, si sarebbe apprestato a indicare estensivamente la città intera. Nel tempo, sarebbe stato utilizzato come sinonimo, giungendo a identificare, per estensione, non solo la città ma l'intero popolo ebraico. Quasi a mostrare plasticamente quel legame con la terra tutt'oggi affermato e ricercato. È quanto suggerisce l'anonimo autore delle Lamentazioni, piangendo sull'esilio dei «figli di Sion» a seguito della conquista di Nabucodonosor del 587-586 a.C. Come non pensare, al riguardo, alle parole di Is 52,1-2, tra le più belle e significative di tutti i libri profetici:
1 Svegliati, svegliati,
rivestiti della tua magnificenza, Sion;
indossa le vesti più splendide,
Gerusalemme, città santa;
perché mai più entrerà in te
l'incirconciso e l'impuro.2 Scuotiti la polvere, àlzati, Gerusalemme schiava!
Si sciolgano dal collo i legami, schiava figlia di Sion!
È l'esultanza per il ritorno dalla dispersione a favorire la trasfigurazione della città nel suo ideale. Ma è al luogo fisico che si pensa. Tale elemento segnerà indelebilmente l'esperienza ebraica.
Il Cristianesimo ha ereditato tale prospettiva, recandola, tuttavia, alle estreme conseguenze. Le descrizioni contenute nella Bibbia ebraica facevano riferimento, sovente, alla trasformazione di luoghi reali, generalmente – ma non necessariamente – oggetto di teofanie, in spazi sacri capaci di trascenderne la collocazione fisica. L'immagine d'un modello "celeste" per la città "terrena" – l'immagine, dunque, d'una Nuova Gerusalemme, in procinto d'adagiarsi sulla Terra – risaliva, in effetti, all'apocalittica ebraica del periodo del Secondo Tempio. Con l'affermarsi della fede nella resurrezione, in età ellenistica, s'era diffusa, inoltre, l'idea per cui tale sarebbe stato il luogo dei salvati. Orbene: gli scrittori cristiani non fecero altro ch'esaltare tale idea, inserendo la Gerusalemme celeste nel piano divino. La cancellazione dei principali luoghi sacri della tradizione giudaico-cristiana, fra il 70 e il 135, per opera di Tito, prima, di Adriano, poi, avrebbe rafforzato la convinzione dell'imminenza della sostituzione della città terrena, ormai irrimediabilmente perduta, con una nuova città: quella celeste. Certo, la prima figurava nelle narrazioni evangeliche e negli Atti degli Apostoli come il luogo in cui Gesù aveva trascorso i suoi ultimi giorni. Nonostante ciò, la città non fu immediatamente avvertita quale luogo precipuo della redenzione universale. Echi della tradizione ebraica s'incontrano, a ogni modo, nella Lettera ai Galati, redatta, verosimilmente, fra il 54 e il 57, in cui Paolo menziona la dicotomia fra la «Gerusalemme attuale […], schiava insieme ai suoi figli», e la «Gerusalemme di lassù»: vera patria, libera dal male e dalla Legge. Tale dualità è approfondita sia dalla Lettera agli Ebrei, sia dall'Apocalisse, il cui commento, nel corso dei primi secoli cristiani, avrebbe contribuito alla cristallizzazione dell'idea d'una Gerusalemme escatologica, destinata a sostituirsi a quella attuale. Non si trattava più solo di una speranza, ma di una certezza inscritta nel disegno divino, che avrebbe alimentato secoli di attese e interpretazioni teologiche. L'idea di una Gerusalemme ultraterrena, pura e immune dalle devastazioni della storia, si sarebbe imposta nettamente, trovando conferme nelle predicazioni patristiche e nei testi liturgici.
Tale complessa eredità sarebbe stata accolta dal pensiero islamico. Non senza resistenze, dovute, in parte, al timore che l'importanza crescente assunta dalla città nell'ambito dei monoteismi concorrenti, ebraico e cristiano, potesse sostituire e, in certo qual modo obnubilare, la primogenitura meccana e medinese. Certo, dalla conquista del 638 – come si dirà, data supposta: i resoconti relativi sono posteriori – sino a quella crociata del 1099, Gerusalemme sarebbe stata dominata dall'universo arabofono. Sin dall'inizio, a ogni modo, avrebbe rivaleggiato con Mecca, salvo perdere di centralità, ora, in favore di Damasco, ora, di Baghdād. Non passerà molto, tuttavia, perché abbia luogo una completa incorporazione nell'orizzonte culturale e religioso islamico. Se, infatti, l'innesto della nuova fede sul ceppo giudeo-cristiano è da ritenersi indubbio – basti pensare al ruolo attribuito a Gerusalemme nel Giudizio finale –, altrettanto certo è l'avvio di tradizioni autonome riguardanti la città. Il pensiero islamico ne avrebbe riconfigurato il significato, concentrandosi, in particolar modo, sull'area del Tempio, il cui recinto avrebbe accolto alcuni tra i principali santuari della nuova fede. Tutt'oggi, l'al-Haram al-Qudsī al-Sharīf, il "Nobile Santuario", è uno spazio sacro per l'Islām, visitato, ogni anno, da decine di migliaia di perone. E ciò, a motivo della sua identificazione col luogo dal quale il Profeta sarebbe partito per il proprio "viaggio notturno". In questo senso, la città intera si pone quale punto di contatto tra la Terra e il Cielo. Come tale, la città diventa oggetto di "visita" (ziyāra) l'atto devozionale con cui i devoti musulmani si recano in una località legata alla storia sacra, non obbligatorio – come il pellegrinaggio alla Mecca, da compiere una volta una volta nella vita – ma meritorio e, dunque, raccomandato. È tale eredità a costituire il bagaglio con cui la città avrebbe affrontato e sostenuto, nel 1099, l'assedio crociato.
E qui si apre una questione: lo spazio, a Gerusalemme, è anche potere. La città è palinsesto, campo di forze. Ogni pietra è un testo, ogni iscrizione è un'argomentazione. Le demolizioni, le ricostruzioni, le dediche, le interdizioni d'accesso, la normativa sui luoghi santi: tutto concorre a stabilire chi possa nominare la realtà e in che termini. La topografia sacra funziona come una grammatica normativa. È accaduto per gli imperi antichi, per il regno crociato, per i sultani mamelucchi e ottomani, per i poteri moderni. Eppure, nella lunga durata, la città non si lascia possedere interamente da nessuno: restituisce sempre eccedenza rispetto a ogni progetto egemonico. Nessuna delle tre tradizioni esaurisce da sola il significato della città: il suo senso nasce dall'attrito e dalla coesistenza dei loro sguardi. Approfondirne, oggi, la storia significa anche interrogare i dispositivi che hanno regolato la convivenza. Si pensi al cosiddetto "Status Quo" ottomano dei Luoghi Santi (XIX secolo), con le sue minuziose consuetudini su chi apre e chi chiude, chi spazza e chi incensa; a guardiani islamici che custodiscono chiavi cristiane; a tridui liturgici che si incastrano a pochi minuti di distanza. È una microfisica del potere che genera frizioni ma anche una pedagogia del limite. Dal lato ebraico, la tensione fra memoria del Tempio e pratiche di preghiera al Muro Occidentale ha prodotto una ricchissima elaborazione giuridica e liturgica sulla santità dei luoghi e sulla distanza da osservarvi. Dal lato musulmano, il regime del waqf – la fondazione religiosa incaricata della gestione dell'al-Ḥaram al-Qudsī al-Sharīf – ha codificato diritti, usi e manutenzioni, trasformando il recinto in un bene religioso e sociale insieme. Dal lato cristiano, il pluralismo confessionale – latini, greci, armeni, siri, copti, etiopi – ha costretto le Chiese a pensarsi non come monadi ma come coordinate in una topografia condivisa. Gerusalemme educa a una teologia della prossimità vigile: non annulla l'altro, lo obbliga a esistere accanto. A ciò si unisce la dimensione del tempo, per nulla lineare. Le tre tradizioni vi celebrano tempi diversi: sabato, domenica, venerdì; calendari che a volte coincidono, più spesso si sfiorano e si scavalcano.
Si dirà: ma tutto questo non è, oggi, schiacciato dalle logiche della forza? Sì, lo è spesso. La "verticalità" della città – quel suo tendere al Cielo – non la sottrae per magia alla gravità della storia. E, tuttavia, proprio questa verticalità impedisce di ridurre Gerusalemme a un semplice teatro di contesa. Perché la contesa, qui, non riguarda soltanto linee di confine e bandiere; riguarda interpretazioni del senso, modi di abitare il limite, criteri di giustizia e di misericordia. La sfida non è negare la sacralità altrui, ma imparare a sostare nella propria senza trasformarla in un possesso esclusivo. Parlare di Gerusalemme, "città delle tre fedi", non equivale, insomma, a neutralizzare le differenze. La promessa ad Abramo, il compimento in Cristo, la rivelazione a Muḥammad non sono intercambiabili; sono, semmai, coordinate che obbligano ciascuno a conoscersi per davvero. La città "orizzontale e verticale" di cui si diceva non è una metafora innocua: è un metodo. Esso chiede di sovrapporre piani senza confonderli: il piano della storia e quello dell'escatologia, il diritto delle comunità e la libertà della coscienza, il culto e la cura civile dello spazio. È qui che Gerusalemme torna ad essere maestra, non malgrado le sue ferite, ma attraverso di esse. Chi la vuole tutta per sé la perde; chi l'abita riconoscendo l'altro la ritrova ogni giorno, come se fosse la prima volta.
Antonio Musarra
