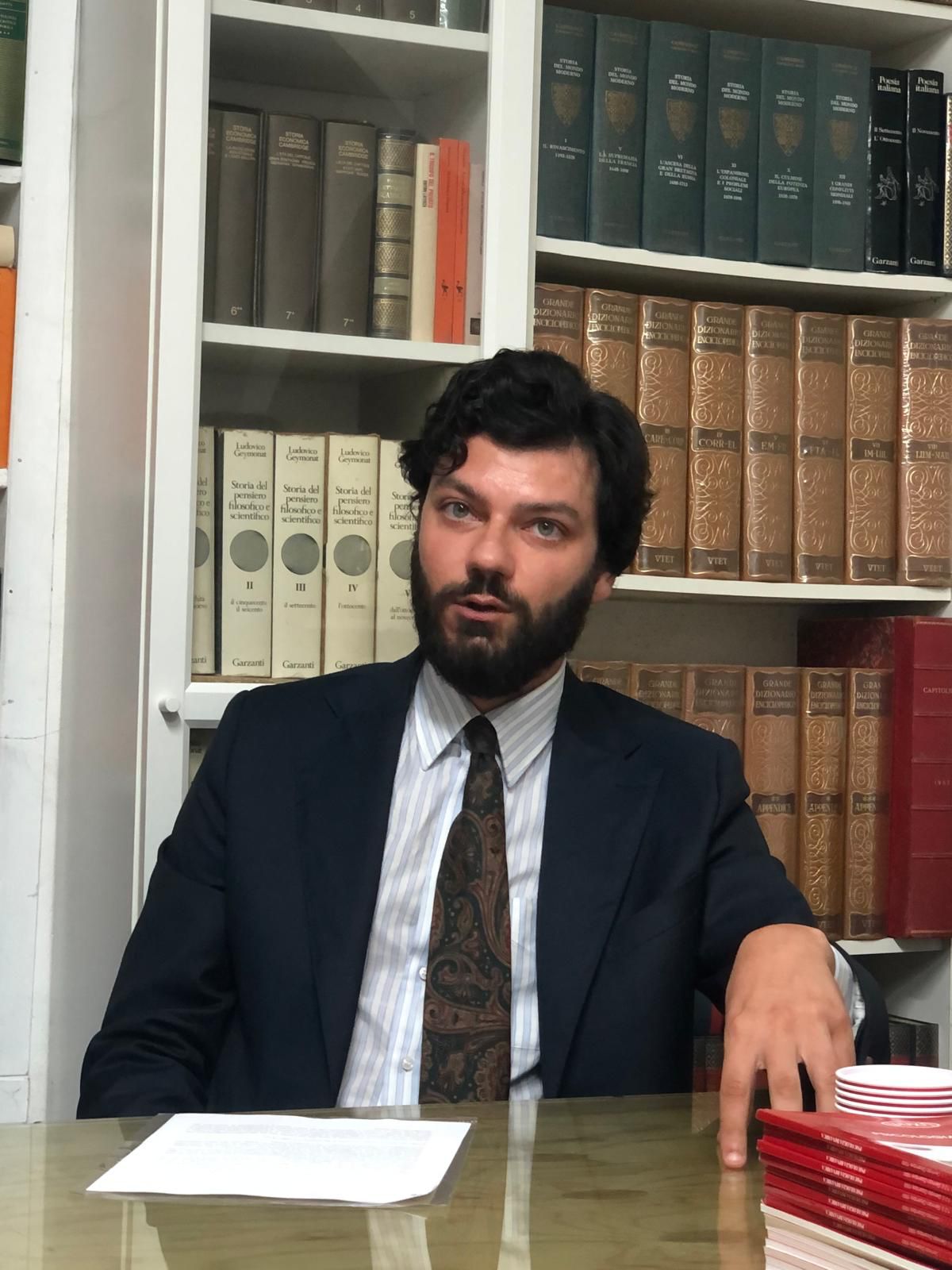Un libro per comprendere la storia passata e presente del Mediterraneo

È fresco di stampa un volume che nasce come manuale per gli studenti universitari di storia ma che può avere un riflesso molto più ampio in campo culturale per il ripensamento di una nuova forma di cittadinanza e di relazione tra i popoli, soprattutto in un momento storico in cui gli affari internazionali sembrano sempre più confusi e polarizzati.
È la Storia del Mediterraneo medievale, curata dal professore Antonio Musarra, dell’Università La Sapienza di Roma e dal professore Pietro Silanos, dell’Università degli Studi di Bari.
L’opera ha coinvolto dieci tra autrici e autori ed è composta da 30 capitoli che seguono un ordine cronologico della storia medievale del Mediterraneo, senza rinunciare ad affondi tematici su argomenti specifici, seguendo un approccio interdisciplinare.
Il volume è diviso in cinque parti: la prima tratta dell’epoca tardoantica, la seconda si concentra sull’Alto Medioevo, la terza sui secoli X-XII e sulle interazioni tra Oriente e Occidente, la quarta sui secoli XII-XIII, mentre l’ultima parte è dedicata alla crisi di un’epoca e alla fase di passaggio verso un mondo nuovo.
Questa storia del Mediterraneo si propone l’intenzione di non analizzare il Mediterraneo come luogo delle opposte aree di influenza, dello scontro di civiltà e delle incomunicabilità. Scopo dichiarato di questo lavoro è quello di incentrarsi sulle interazioni, cioè sulle relazioni tra i popoli e le civiltà che hanno popolato questo mare, in un’ottica pluridisciplinare. Il testo dimostra come, nonostante le interazioni tra le civiltà mediterranee siano state ora di concordia ora di scontro, non sono mai venute meno la cooperazione e la condivisione di una prospettiva di conoscenza.
Così, nel corso della trattazione accademica, gli autori mostrano ai lettori le rotte dei pellegrinaggi verso Gerusalemme e La Mecca, i tragitti dei viaggiatori come Ibn Battuta mossi dal desiderio di conoscere e apprendere, il fervore di Baghdad, Roma, Palermo, Toledo, Bisanzio, Alessandria, le corti dell’Oriente e dell’Occidente in cui sapienti ebrei, cristiani e musulmani si sostenevano reciprocamente nella ricerca intellettuale.
Durante l’evento di presentazione del volume il professore Musarra ha spiegato come, nella redazione di questo manuale, oltre a un’esigenza di carattere didattico, si è cercato di soddisfare un’esigenza di natura civica e civile che consiste nel “far prendere coscienza agli studenti di quanto sia importante recuperare il senso di una cittadinanza prettamente mediterranea non solo relativamente alla storia medievale ma anche a quella contemporanea. Conosciamo troppo poco il Mediterraneo e sarebbe invece importante realizzare questa conoscenza, allargando lo sguardo oltre l’Europa senza disconoscerne l’importanza”.
Nel capitolo di introduzione al volume i due curatori scrivono a proposito del Mediterraneo:
“Non di rado, però, la medievistica contemporanea ne ha fornito una lettura parziale, focalizzata su prospettive eurocentriche, oltre che legate strettamente alla dimensione terrigena, trascurando il contributo fondamentale dato da quelle culture e civiltà diverse dal contesto latino che ne hanno plasmato la storia. È il caso, ad esempio, dell’universo islamico, così come delle influenze provenienti dall’Africa settentrionale, dal mondo bizantino, dall’Asia Minore e dal Levante in genere, spesso marginalizzate o trattate in modo frammentario. Una visione più inclusiva dovrebbe prendere in considerazione non solo i rapporti tra le potenze europee ma anche le interazioni complesse e multilaterali tra mondi contermini, favorendone una comprensione più equilibrata. In questo senso, l’approccio tradizionale si dimostra incompleto. Abbracciare una prospettiva più ampia, che integri l’Europa, l’Africa e l’Asia permette di cogliere a pieno la complessità delle reti di scambio, delle diaspore e dei processi di acculturazione che hanno reso quest’area un crocevia di popoli e culture. Il mare magnum, insomma, è sì un luogo di confronto ma anche di cooperazione e reciproca influenza: un laboratorio di relazioni che hanno contribuito a formare le civiltà moderne”.
Nel capitolo dedicato alla religiosità mediterranea il professore Silanos spiega l’importanza degli incroci tra popoli in virtù della pratica rituale del pellegrinaggio e delle peculiarità dell’ascetismo ebraico, cristiano e musulmano. Nello stesso capitolo si mostra anche come riconoscere i germi della divisione interna alle culture e della discriminazione verso le minoranze che partono da arroganze politiche e manipolazioni dottrinali per arrivare a espulsioni, costrizioni e ostilità, come nel caso delle violenze perpetrate contro le minoranze ebraiche.
Nei capitoli curati dal professore Giuseppe Mandalà, dell’Università di Milano, ci si concentra sulla centralità delle interazioni. Il Mediterraneo medievale è uno spazio di civiltà diversificate ma che hanno interagito con relazioni su più livelli: dal piano del confronto tra le religioni abramitiche fino a quello diplomatico e culturale. L’Europa dunque non appare come un sistema chiuso e la mobilità medievale non è solo connessa agli affari e ai commerci ma anche, e soprattutto, al pellegrinaggio, agli scambi, alle ambascerie, alle esplorazioni.
Questa “polifonia di culture”, come la definisce Mandalà, che sa interagire al di là delle differenze è armonica quando è orientata secondo una prospettiva intellettuale che non è esclusiva e non mira ad azzerare le differenze o a omologare tutti i popoli.
Ecco dunque perché oggi può essere utile la riscoperta delle radici medievali dell’Europa e del Mediterraneo sostenuta dalla lettura di questo libro: in un’epoca di disordini e divisioni, di psicosi belliciste e di polarizzazioni, il Medioevo mediterraneo può indicare all’Europa una prospettiva di unità e integrazione che non è solo diplomatica ma è necessariamente intellettuale.
Le analisi strategiche non servono a nulla finché gli europei non saranno in grado di ricordare quale sia la loro origine e quali siano le loro radici. La “tolleranza” non è efficace se non si realizza veramente che nella diversità c’è il segreto per la realizzazione dell’Unità. Non si tratta dunque di ripercorrere le strade dei viaggiatori medievali o le rotte degli esploratori ma di riscoprire il simbolo di questi movimenti che è la ricerca della Conoscenza.
È un segnale particolarmente importante che il mondo accademico stia maturando una sensibilità per un contribuito a un rinnovamento intellettuale dell’idea di cittadinanza mediterranea e di dialogo tra popoli vista l’urgenza di una necessità di cambiamento della prospettiva. La pericolosa fase di caos che il mondo sta attraversando ci impone infatti un nuovo ritmo e un cambio di passo e paradigma rispetto ai mutamenti dei rapporti tra i popoli e agli spettri delle guerre.